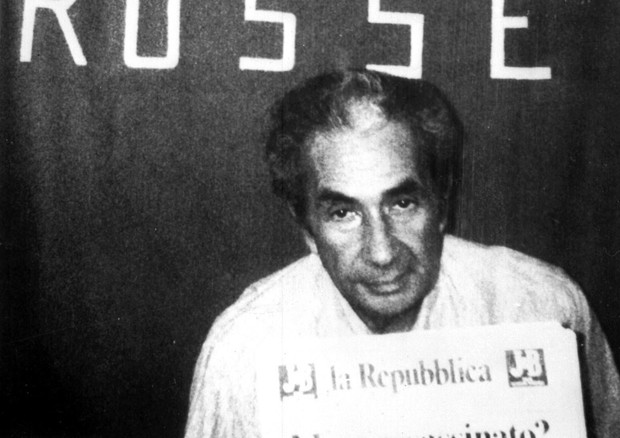-
PODCARDS: La montagna di Sainte-Victoire di Paul Cézanne
La montagna di Saint- Victoire fu uno dei soggetti più cari a Paul Cezanne.
L’artista lavorò instancabilmente a questo soggetto per oltre vent’anni producendo una vasta quantità di dipinti, acquerelli e disegni.
La osserva a lungo e la dipinge con entusiasmo, utilizzando il colore come puro mezzo per ricostruire sulla tela la sua personale visione della natura. Attraverso una pennellata ampia e veloce avvia quel processo di sinterizzazione delle forme, che lo condurrà a un passo dall’astrazione.
Nelle sue tele i dipinti prendono vita attraverso un concerto di passaggi tonali.
In questo turbinio di colori e forme semplificate, solo il profilo del monte, che svetta maestoso sulla valle di Aix-en-Provence, rimane ben riconoscibile all’orizzonte.
-
L’arte di Jaro Varga in ‘we don’t know what we know‘
-
Beata solitudo, sola beatitudo
Era giugno inoltrato. Erano seduti attorno a un tavolinetto rotondo, tutti ancora nei loro abiti di scena. Alteri e orgogliosi, sembrava stessero recitando, anche lì, in quel frangente. Chissà se quella sera, prima di prendere posto nel locale, erano stati padri, fratelli, medici, assassini, amanti o amati.
Li osservavo impalata nel mio bell’abito verde e, per un attimo, mi feci cullare dal pensiero che anche io avrei potuto essere una di loro. Con una trama definita e mai più sola.
Sempre affascinata dal mondo degli attori, mi incuriosiva l’idea che vivessero per quell’attimo di riconoscenza in cui, a fine spettacolo, il loro volto si rispecchiava negli occhi luminosi di un pubblico grato.
Mi guardai intorno e mi resi conto che in fondo era tutto un grande teatro. Anche io avrei dovuto recitare per avere la possibilità di stare al mondo?
Perfino il locale sembrava una quinta teatrale. Sulle pareti erano dipinte ingenuamente una balaustra di pietra bianca, il mare blu, il cielo turchese e tante colorate lanterne di carta.
Con una trama definita e mai più sola, continuavo a ripetermi in testa.
Sarei stata spettatrice di un mondo nel quale non mi riconoscevo? O mi sarei finalmente confusa tra la gente, accettando il compromesso, ma godendo dei privilegi dell’appartenenza?
Con una trama definita e mai più sola.
Decisi così di abbandonare il locale e salire sulla corriera, tutta vecchia, con le panche in legno e semivuota, che mi avrebbe portata a casa. Fuori dai finestrini piccoli, la luce infinita della sera. Il mio sguardo, smarrito ed estasiato, venne catturato da un piccolo teatro poco illuminato. Impulsivamente chiesi all’autista di fermarsi.
Mi ritrovai davanti alla porta d’ingresso del teatro, nella penombra. Se fossi entrata sarei diventata un’attrice. Finalmente sarei stata parte di qualcosa, con una trama definita e mai più sola.
Bussai. Ad un tratto alzai lo sguardo e vidi il mio riflesso sulla porta a vetri dell’ingresso. Sentii una voce che urlava ̶ arrivo! ̶ . Mi guardai attraverso quel riflesso e di scatto mi voltai per andare via, mentre la porta alle mie spalle si apriva.
Era chiaro che, nonostante i mille tentativi di riconoscermi in qualcosa, in fondo, sarei sempre stata io. Ella. Con una trama indefinita e per sempre sola.

Edward Hopper, Soir Bleu 1914 -
L’arte di Jeff Koons